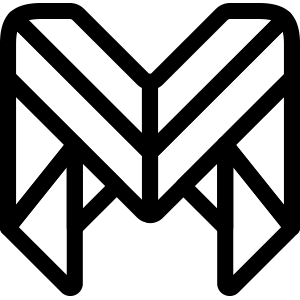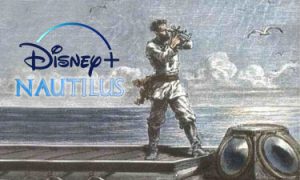La Festa del Papà mi sembra una buona occasione per fare qualche riflessione estemporanea intorno ad un’opera che ha come fulcro centrale il senso di inadeguatezza costante del padre “contemporaneo”: In viaggio con Pippo.
Chi è nato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 ha conosciuto In viaggio con Pippo principalmente grazie alla televisione, facendone un vero e proprio cult generazionale. Da adolescenti, molti di noi adolescenti si sono identificati in Max, con la sua voglia di indipendenza e il senso di imbarazzo verso un padre ritenuto fuori luogo. Ora, con il passare del tempo, quella stessa generazione si trova dall’altra parte: come genitori o adulti, rilegge il film con una nuova consapevolezza, riconoscendo nella goffaggine di Pippo una dimensione universale della paternità.

Proprio in quegli anni, la figura paterna ha vissuto una trasformazione radicale. Se il padre delle generazioni precedenti era spesso distante e autoritario, il padre contemporaneo è chiamato a un ruolo più complesso, fatto di presenza emotiva e a cui si richiede una costante partecipazione. Pippo incarna questa transizione: la sua volontà di trascinare Max in un viaggio “padre-figlio” nasce dal timore di perdere il proprio posto nella vita del ragazzo, ma l’evoluzione della loro relazione lo porta a comprendere l’importanza dell’ascolto e della condivisione.
La trama segue il loro viaggio on the road, nato dal desiderio di Pippo proprio di riconnettersi con Max, il quale lo vede come un ostacolo alla propria emancipazione. Questo conflitto generazionale è un tema del film e riflette una società in cui la figura paterna tradizionale – autoritaria e distante rappresentata nel film da Pietro Gambadilegno – lascia spazio a un modello più vulnerabile, empatico, ma spesso percepito come inadeguato.
In quasi tutta la letteratura del Novecento, la figura dell’inetto si è imposta come simbolo della scarsa propensione dell’individuo di adattarsi alle trasformazioni sociali e culturali. Pippo, con la sua goffaggine e il suo disorientamento esistenziale (tratti tipici del personaggio), si colloca perfettamente in questa tradizione.
Tuttavia, diversamente dai modelli novecenteschi, il protagonista Disney non è condannato all’inerzia o all’autoanalisi paralizzante. La sua inadeguatezza genitoriale si traduce in un viaggio iniziatico in cui l’errore e il fallimento non sono segnali di debolezza bensì tappe necessarie di un percorso di crescita tipiche del romanzo di formazione.
Pippo non si conforma al modello tradizionale del padre autoritario e risoluto, e neppure a quello del genitore condiscendente, bensì la sua figura si pone in un punto di equilibrio tra affetto e difficoltà comunicative.
Da questo punto di vista Pippo è un padre “postmoderno”: non ha tutte le risposte, ma il suo amore incondizionato per Max diventa il motore di una relazione che si ricostruisce chilometro dopo chilometro, fino al toccante finale al concerto di Powerline, dove padre e figlio ballano insieme, simbolicamente riconciliati.
Dal punto di vista filosofico, il viaggio che Max compie insieme a Pippo può essere interpretato attraverso il concetto freudiano di “uccidere il padre”, ovvero il processo simbolico attraverso cui l’adolescente deve superare la figura paterna per affermare la propria identità. Il conflitto tra i due personaggi si fonda sulla difficoltà di Max di emanciparsi da un padre che considera ingombrante e imbarazzante, mentre Pippo fatica ad accettare il cambiamento e l’autonomia del figlio, non riconoscendone le esigenze mutate.

Il viaggio diventa così una metafora della crescita: Max, nel tentativo di distanziarsi dal padre, si trova invece costretto a confrontarsi con lui, a comprenderlo e, infine, ad accettarlo nonostante le sue imperfezioni. Questo processo riflette la tensione universale tra la necessità di separarsi dai genitori e il bisogno di riconoscerne il valore.
Il fatto che Max rischi l’espulsione dalla scuola non è necessariamente un segno di trascuratezza paterna, ma piuttosto un sintomo delle tensioni tipiche del rapporto padre-figlio nell’adolescenza. Il film suggerisce che l’essere un buon genitore non significa evitare del tutto i problemi, ma affrontarli con amore, dedizione e la volontà di crescere insieme al proprio figlio.
In viaggio con Pippo ci ricorda che essere padre oggi significa accettare le proprie imperfezioni e trasformarle in opportunità di dialogo. L’inettitudine di Pippo, che potrebbe farlo apparire ridicolo agli occhi di Max, diventa invece il ponte per un’intimità ritrovata. Non è un caso che il film si chiuda con un gesto di complicità: Pippo aiuta Max a conquistare Roxanne, dimostrando che un padre non deve solo guidare, ma anche sostenere i sogni dei figli.